- Dettagli
- Scritto da Barbara de Munari
- Visite: 1095
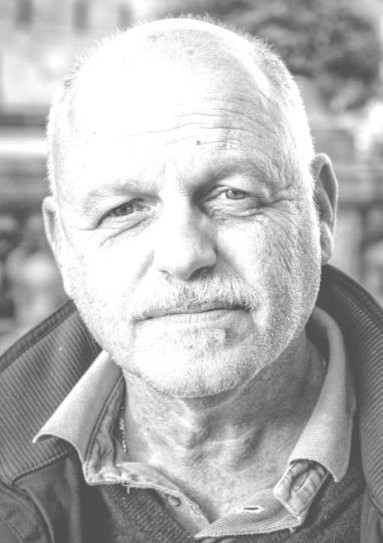
Anche il dolore va porto con gentilezza; non deve essere comunicato o condiviso come fosse una frustata, ma come un abbraccio, come una stretta di mano, come uno sguardo lucido e penetrante.
Anche il dolore merita rispetto e decoro; come un cuore che sanguina, deve essere curato; come un pianto a dirotto, deve essere confortato; come un urlo, deve essere sfogato.
Come un addio, deve essere benedetto.
Anche il dolore deve essere compreso e capito; un lamento va accolto e ascoltato; una delusione deve essere accarezzata; un tradimento va compreso.
Tutto ciò affinché il dolore resti tale, ma recluso in una bolla, che non prenda mai posto nella culla dell' anima...
©Alessandro Yoram Nathan Scuderi
- Dettagli
- Scritto da Barbara de Munari
- Visite: 882

Prima dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, nel giugno dello stesso anno, SS tedesche, affiancate da reparti della X MAS, massacrarono 72 persone a Forno. Il 19 agosto, varcate le Apuane, le SS si spinsero nel comune di Fivizzano (Massa Carrara), seminando la morte fra le popolazioni inermi dei villaggi di Valla, Bardine e Vinca, nel comune di Fivizzano. Nel giro di cinque giorni uccisero oltre 340 persone, mitragliate, impiccate, financo bruciate con i lanciafiamme.
Nella prima metà di settembre, con il massacro di 33 civili a Pioppetti di Montemagno, in comune di Camaiore (Lucca), i reparti delle SS portarono avanti la loro opera nella provincia di Massa Carrara. Sul fiume Frigido furono fucilati 108 detenuti del campo di concentramento di Mezzano (Lucca), mentre a Bergiola i nazisti fecero 72 vittime. Avrebbero poi continuato la strage con il massacro di Marzabotto.
È la scia di terrore insensato che ha già sconvolto e continuerà a sconvolgere tante comunità italiane. A Sant’Anna cala il silenzio. Resta la disperazione dei sopravvissuti per i quali la guerra non finirà mai più.
Ci vorranno 60 anni prima che inizi il processo: 20 aprile 2004, Tribunale Militare di La Spezia. Nel 1994 erano stati ritrovati casualmente a Palazzo Cesi, negli archivi della procura generale militare di Roma, 695 fascicoli sui crimini di guerra commessi dai nazifascisti dopo l’8 settembre 1943. Erano nell’ “armadio della vergogna”, faldoni portati alla luce e studiati dal formidabile lavoro di indagine di un giornalista, Franco Giustolisi.
Nell'estate del 1994, Antonino Intelisano (il procuratore militare di Roma), mentre cerca documentazione su Erich Priebke e Karl Hass, avvia un procedimento che porterà alla scoperta casuale, in uno scantinato della procura militare, di un armadio contenente 695 fascicoli «archiviati provvisoriamente», riguardanti crimini di guerra commessi da tedeschi e repubblichini. Tra questi viene trovata anche della documentazione relativa al massacro di Sant'Anna, per il quale verrà riaperta l'inchiesta che porterà a individuare alcuni dei responsabili.
Il procuratore militare di La Spezia Marco De Paolis (in seguito procuratore militare di Roma) grazie a indagini accurate riesce a individuare i responsabili di questo eccidio. È così che il 20 aprile 2004, davanti ai giudici del Tribunale Militare di La Spezia viene celebrato un processo per i responsabili di questo crimine. Sono passati dieci anni dalla scoperta dei fascicoli delle stragi "abbandonati" nell'armadio dello scantinato della procura militare di Roma, ma prima di de Paolis nessuno aveva pensato di fare indagini su questa e altra strage nazista di Sant'Anna.
Poiché tra soldati e ufficiali gli imputati sarebbero stati centinaia, fu deciso di rinunciare a processare i soldati - esecutori materiali dell'eccidio - per processare solo gli ufficiali che di quell'eccidio erano stati i veri responsabili, essendo stati loro a dare l'ordine del massacro.
Il giudice dell'udienza preliminare accolse quindi la richiesta del procuratore militare De Paolis di rinvio a giudizio per i tre ufficiali SS accusati di essere gli esecutori dell'eccidio. Tra i militari tedeschi accusati: Gerhard Sommer, 83 anni, comandante della 7ª compagnia del II battaglione del 35º reggimento Grenadieren (facente parte della 16. SS-Panzergrenadier-Division "Reichsführer-SS"), gli ufficiali Alfred Schöneberg, 83 anni, e Ludwig Heinrich Sonntag, 80 anni. Per altre due SS, Werner Bruß, 84 anni, e Georg Rauch, 83 anni, fu richiesto il non luogo a procedere, mentre per Heinrich Schendel, 82 anni, il Gup rinviò gli atti al pubblico ministero fissando il termine massimo di 5 mesi per ulteriori indagini.
Il 22 giugno 2005 il procuratore De Paolis chiede la condanna all'ergastolo per dieci tra ex ufficiali e sottufficiali tedeschi. Il tribunale militare di La Spezia accoglie la richiesta. Al momento della sentenza i dieci erano tutti ultraottantenni.
La ricostruzione degli avvenimenti, l'attribuzione delle responsabilità e le motivazioni che hanno originato l'eccidio sono state possibili grazie al processo svoltosi al Tribunale militare di La Spezia, conclusosi nel 2005 con la condanna all'ergastolo per dieci SS colpevoli del massacro; sentenza confermata in Appello nel 2006 e ratificata in Cassazione nel 2007. Nella prima fase processuale si è svolto, grazie al pubblico ministero Marco De Paolis, un imponente lavoro investigativo, cui sono seguite le testimonianze in aula di superstiti, di periti storici e persino di due SS appartenute al battaglione che massacrò centinaia di persone a Sant'Anna.
L'8 novembre 2007 vennero confermati dalla Corte di cassazione gli ergastoli all'ufficiale Gerhard Sommer e ai sottufficiali nazisti Georg Rauch e Karl Gropler. La Cassazione si è espressa contro la richiesta di rifare il processo in quanto i soldati delle SS sentiti come testimoni dovevano essere considerati coimputati e quindi le loro testimonianze non valide. La sentenza rigetta questa tesi e conferma che l'eccidio è stato un atto terroristico premeditato. Su iniziativa parlamentare del deputato Carlo Carli e altri, con legge 15 maggio 2003, n. 107, viene istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta per indagare sulle anomale archiviazioni "provvisorie" e sull'occultamento dei 695 fascicoli (compresi quelli relativi alla strage di Sant'Anna di Stazzema) contenenti denunzie di crimini nazifascisti.
Il 1º ottobre 2012 la Procura di Stoccarda ha archiviato l'inchiesta per la strage nazista. L'organo giudiziario tedesco ha deciso l'archiviazione innanzitutto perché, secondo i magistrati, non sarebbe più possibile stabilire il numero esatto delle vittime: nella regione si trovavano anche numerosi rifugiati di guerra provenienti da altre zone. I reati di omicidio e concorso in omicidio per l'eccidio non sono prescritti; tuttavia, secondo la Procura tedesca, sarebbe stato necessario, per l'emissione di un atto di accusa, che venisse comprovata per ogni singolo imputato la sua partecipazione alla strage. E ciò non è stato ritenuto possibile dagli inquirenti tedeschi. Secondo la magistratura tedesca, inoltre, non sarebbe possibile accertare se la strage sia stata effettivamente un atto premeditato contro la popolazione civile, in quanto (sempre secondo la Procura di Stoccarda) è possibile che gli obiettivi dell'azione militare siano stati solo la lotta antipartigiana e il rastrellamento di uomini da deportare ai lavori forzati in Germania. Tale decisione, che è in contrasto con le risultanze processuali della magistratura italiana, ha suscitato incredulità e sdegno fra i sopravvissuti alla strage e prese di posizione contrarie da parte di vari esponenti politici in Italia.
Il processo sull’eccidio di Sant’Anna, portato avanti dal procuratore Marco De Paolis e da un gruppo di colleghi, carabinieri, interpreti, storici, consulenti, arriva a sentenza il 22 giugno 2005 con la condanna all’ergastolo di 10 ex appartenenti alle SS. Indagati complessivamente 24 militari, 8 le archiviazioni per morte del reo, 5 archiviazione per insufficienza di prove, 1 sospensione per motivi di salute. L’autorità tedesca non ha dato esecuzione alle sentenze. Alcuni dei condannati hanno potuto invecchiare liberi e poi sono morti, alcuni troppo malati per scontare in carcere la pena, altri condannati ma liberi.
Ecco i nomi:
Anton Galler, archiviato per morte del reo; Theodor Sasse, archiviato per insufficienza di prove; Alfred Leibssle, archiviato per morte del reo; Alfred Lohmann, archiviato per insufficienza di prove; David Pichler, archiviato per insufficienza di prove; Karl Gesele, archiviato per morte del reo; Friederich Crusemann, archiviato per morte del reo; Ernst Karpinski, archiviato per morte del reo; Rupert Lesiak, archiviato per morte del reo; Karl Segelken, archiviato per morte del reo; Kurt Osinger, archiviato per morte del reo; Otto Glanznig, archiviato per insufficienza di prove; Alfred Baumgart, sospensione della pena per malattia, poi deceduto; Horst Eggert, archiviato perché morto prima del processo; Gerhard Sommer, ergastolo; Alfred Schonenberg, ergastolo; Werner Bruss, ergastolo; Heinrich Schendel, ergastolo; Heinrich Sonntag, ergastolo; Georg Rauch, ergastolo; Horst Richter, ergastolo; Alfred Concina, ergastolo; Karl Gropler, ergastolo; Ludwig Goring, ergastolo.
- Dettagli
- Scritto da Barbara de Munari
- Visite: 863
L’avvocato Siegel e il signor Sanden
A volte, non interpretare velocemente o correttamente un punto di passaggio storico, uno snodo di non ritorno, può essere fatale.
Nell'agosto del 1940 l'avvocato Siegel, Ebreo tedesco, e la sua famiglia, organizzano una fuga dalla Germania nazista, da cui riescono a scappare: un lungo viaggio che parte da Berlino, passando per la Russia sulla Transiberiana, attraversando Corea e Giappone. Da qui una nave li porterà in America, ma loro andranno fino in Perù.
La storia dell’avvocato Siegel inizia sette anni prima: il 10 marzo 1933. Sono passate poche settimane da quando Adolf Hitler è salito al potere. In Germania qualcosa sta cambiando. In molti guardano curiosi agli sviluppi della politica interna tedesca, senza capire bene cosa stia realmente accadendo. Assistono. I nazionalsocialisti si insediano - legittimamente - nei municipi, come a Monaco. Si sono subito messi all'opera, girando per le strade della città e prendendo di mira i negozi dei commercianti ebrei. Minacce perlopiù, ma in alcuni casi si passa alle maniere forti.
Il signor Max Uhlfeder, proprietario del secondo grande magazzino più importante della città, si avvia come ogni giorno al lavoro. Quel che trova al suo arrivo è solo distruzione: vetrine sfasciate e gli interni, gli arredi, la merce, devastati dalla furia degli uomini delle SA. Questi, non contenti, arrestano lo stesso Uhlfeder che, con altre 280 persone, è trasportato nel campo di Dachau in "custodia protettiva", come si legge nel documento redatto dagli ufficiali. Gli arrestati sono tutti Ebrei.
Il suo avvocato, il signor Michael Siegel, viene contattato dalla famiglia dell'imprenditore, e subito si attiva. Valigetta alla mano, entra negli uffici della polizia per sporgere denuncia, quell'arresto non aveva alcun senso, Uhlfeder non aveva commesso alcun reato, i suoi diritti civili erano stati ignorati. Seduti alla scrivania, però, Siegel non trova i soliti ufficiali di polizia, ma uomini in divisa che indossano camice brune. Sono gli uomini delle Sturmabteilung, un gruppo paramilitare del partito nazista.
Siegel inizia a esporre la questione, ma da dietro la scrivania partono solo risate. Risate che si trasformano in insulti. E dagli insulti si passa alla violenza. Siegel viene colpito al volto, poi viene preso di forza e portato nel seminterrato del municipio, dove viene picchiato pesantemente. Poi, tramortito, lo caricano di peso e lo portano fuori dagli uffici. Un uomo con un cartello gli si avvicina, lo costringe a stare dritto e immobile: glielo deve mettere addosso. Su questo una scritta, un monito: "Ich bin Jude aber ich will mich nie mehr bei der Polizei Beschweren (sono Ebreo ma non voglio mai più lamentarmi con la polizia)".
Siegel è costretto a camminare per le strade di Monaco, seguito da un drappello di sette uomini delle SA, che marciano baldanzosi, mentre raccolgono qualche approvazione da parte delle persone che si fermano a osservare la scena. Altri rimangono di pietra, vedendo quell'uomo ferito e pestato a sangue sfilare con quella scritta appesa al collo. Il piccolo corteo arriva fino alla stazione centrale. Siegel rimane eretto, il sangue che gli cola sugli occhi pesti, fino alla bocca. Le SA gli intimano di fermarsi, caricano i fucili, glieli puntano addosso. L'ufficiale lo schernisce, poi dice: "Jetzt stirbst du, Jud! - Ora morirai, Ebreo". Poi scoppiano a ridere, fanno dietro front e se ne vanno.
Siegel è sconvolto, vuole e deve tornare a casa dalla sua famiglia. Si incammina tra la folla, qualcuno continua a deriderlo. Tra questi, però, si trova il fotografo Heinrich Sanden. Con la sua macchina fotografica aveva immortalato quanto accaduto all'avvocato. Si avvicina a Siegel e gli chiede: "Ho il suo permesso di pubblicare le foto che le ho scattato?".
La risposta di Siegel è secca: "Sì".
Il fotografo intuisce immediatamente l'importanza di quelle foto, ma allo stesso tempo il rischio che rappresentano: se lo dovessero trovare in possesso di quegli scatti farebbe di certo una pessima fine.
Chiama un'agenzia giornalistica americana con sede a Berlino.
La redazione gli compra le foto e gli dice di inviarle appena possibile.
Le foto partono per gli USA, Washington DC. Il 23 marzo 1933 il Washington Times le pubblica. Le foto fanno il giro del mondo.
Sanden continuò la sua attività di fotoreporter, ma quell'esperienza, quella scena di quell'uomo umiliato in una pubblica piazza, non la dimenticò mai. E come lui tante altre persone. La gente cominciò a capire che in Germania qualcosa stava cambiando e che forma questo cambiamento stesse prendendo.
L’avvocato Siegel divenne, a propria insaputa, un simbolo internazionale della persecuzione antisemita in Germania e non apprese della foto fino agli anni '70.
Nonostante il clima crescente di violenza e di discriminazione antisemita, l’avvocato Siegel e la sua famiglia rimasero a Monaco. Gli fu revocato il passaporto nel 1934 e reintegrato nel 1935. Poi gli agricoltori locali avvertirono il dottor Spiegel dell'imminente Kristallnacht, il 9 novembre 1938. Fuggì in Lussemburgo e tornò alcune settimane dopo, solo per perdere la licenza legale. All'inizio del 1939 la famiglia Siegel lasciò la propria casa e trovò un altro alloggio. Il loro nuovo piano terra fungeva da sinagoga di emergenza, i nazisti avevano raso al suolo la sinagoga principale della città. Il figlio diciottenne del dottor Siegel, Peter, e la figlia quattordicenne Beate, emigrarono presto in Inghilterra.
L’avvocato Siegel e la moglie Mathilde chiesero asilo in Perù. Il cammino per il Perù iniziò nell’agosto 1940. Attraversarono la Lituania, la Siberia, la Russia e il Giappone, prima di arrivare in Perù.
Siegel iniziò a lavorare in una libreria di Lima. Negli anni del dopoguerra, lavorò per stabilire un'ambasciata per la Repubblica Federale di Germania nella capitale del Perù, Lima. Ben presto divenne rabbino della comunità ebraico-tedesca a Lima.
Nel 1953, l’avvocato Siegel poté nuovamente esercitare la professione forense in Germania, e aiutò i rifugiati ebrei tedeschi in Perù e in altre parti dell'America Latina.
Nel 1971, all'età di 89 anni, ricevette la Gran Croce al Merito della Repubblica tedesca "in riconoscimento dei suoi eccezionali servizi allo Stato e al popolo".
Accettò il premio in nome di tutti gli ebrei tedeschi a Lima e non smise mai di perseguire i casi di restituzione post-bellica.
Morì nel 1979 all'età di 97 anni.
Non portava rancore nei confronti del popolo tedesco, perché aveva conosciuto anche persone decenti.
Un giorno gli chiesero cosa stesse pensando durante il pestaggio. Senza mezzi termini la risposta dell'avvocato fu: "che sarei sopravvissuto a ognuno di loro".

- Dettagli
- Scritto da Barbara de Munari
- Visite: 828

Riflessioni nel Tempo del Male
Il filosofo Günther Anders (1902-1992) trasforma il motto di René Descartes (cogito ergo sum) in un cogitor ergo sum in versione laica: «Mi si pensa, dunque sono», riferendosi alla condizione esistenziale dell’uomo del XX secolo, alle tragedie della seconda guerra mondiale e della Shoah, della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki e, per quanto lo riguarda direttamente, alla sua situazione di profugo ed espatriato.
Tutto, nel suo pensiero maturo, induce alla necessità di una riflessione sulla correlazione fra gli esseri umani. Marito di Hannah Arendt e cugino di Walter Benjamin, costretto a fuggire dalla Germania nel 1933 per le sue origini ebraiche, Anders scrive: «Io non ho avuto una vita. Non ricordo. Gli emigranti non ci riescono. Di quel singolare, 'la vita', noi, incalzati dalla storia universale, siamo stati defraudati».
Anders si addentra con lucidità e amarezza in quella che a fatica menziona come vita (citata in latino nei suoi scritti) perché quello che gli è accaduto, i continui trasferimenti, prima a Parigi, poi in America, a New York e a Los Angeles, per fare ritorno in Europa nel 1950, stabilendosi a Vienna, con tutto quello che hanno significato in perdita di dignità e identità, lo hanno lasciato muto, spossessato di quelle qualità dell’esistenza che la possono rendere umana.
Costretto a fuggire dalla Germania nazista, Günther Anders (registrato come Günther Siegmund Stern nei registri della comunità ebraica di Breslavia nel 1902) visse una vita da escluso, trascinandosi dietro un bagaglio apocalittico, come testimonianza di quella crisi del tempo lineare, il tempo del progresso, che Anders aveva declinato fin dalle prime opere.
Figlio dell'illustre psicologo Wilhelm Stern, ricevette una solida formazione umanistica. Assimilato come ebreo tedesco, allievo di Martin Heidegger e di Edmund Husserl, completò con quest'ultimo la sua tesi in filosofia nel 1923. Lo pseudonimo ‘Anders’ nacque da un invito del suo editore di Berlino a cambiare il suo cognome, Stern, in quanto era assai comune tra gli scrittori in Germania, suggerendo “qualcosa di diverso” (etwas anders in tedesco). Lui prese alla lettera il suggerimento e decise di chiamarsi “diverso”.
Sposò nel 1929 Hannah Arendt, la sua brillante e inquieta allieva prediletta, da cui avrebbe divorziato nel 1937: il pessimismo di Anders era “difficile da sopportare”, confesserà lei in seguito, rivolta a Elfride Heidegger, mentre Anders, in un suo libro autobiografico, definirà la sua relazione con la Arendt come «il più grande amore della sua vita», anzi, «il primo e l’unico». Entrambi poi si risposarono, lui, dal 1945 al 1955 fu sposato con la scrittrice austriaca Elisabetta Freundlich; poi nel 1957 si sposò con la pianista ebreo-americana Charlotte Lois Zelka, morta nel 2001.
Lei, nel 1940, sposò il poeta e filosofo tedesco Heinrich Blücher, con cui nel 1941 emigrò negli Stati Uniti d'America.
Anders e Arendt non si lasciarono mai, in realtà, e rimasero sempre in contatto – anche da una sponda all’altra dell’oceano – sia durante la guerra, sia dopo, quando entrambi intrapresero le loro personali riflessioni sul Male e sulle sue cause contingenti. Un amore destinato e inevitabile.
Scrive Anders: «Chiaramente il fatto che noi non abbiamo avuto una vita non significa che la materia della nostra esistenza sia stata povera. Se potessi radunare intorno a me tutte le figure che un giorno ho impersonato, o che mi hanno portato sulle loro spalle nel tempo e nello spazio fino a questo qui e ora, se potessi impilare dinanzi a me tutti i faits divers che mi sono capitati, ebbene, per numero e quantità tutto ciò arriverebbe a costituire una ricca esistenza umana. E tuttavia non emergerebbe nessuna singola vita, ma solamente vitae. Solamente vite, al plurale».
Coraggio, malinconia, vergogna sono termini che tornano spesso in queste riflessioni. Il coraggio di «lasciarsi dare del codardo o del traditore», di vivere un’esistenza controcorrente, e spesso da oppositore, subendo ogni tipo di isolamento. Ma anche l’abisso della malinconia e della nostalgia, e la vergogna per le umiliazioni affrontate, per aver dovuto vivere mesi e mesi solo pensando a sopravvivere. «Hanno vissuto – sottolinea Anders – nella vergogna, per esempio, tutti quelli che, tradotti in un lager con la prospettiva di divenire rifiuti, sono stati costretti a trascorrere i giorni che restavano loro nell’attesa di essere eliminati. Rispetto a questa, la nostra vergogna era evidentemente puro privilegio. In effetti, chi è ancora vivo sente l’ingiustizia di tale privilegio come una vergogna ulteriore; ed esiste qualcosa come una comunità, piena di vergogna, composta da quelli che per caso non sono finiti nelle camere a gas».
Hannah Arendt, invece, pur se toccata e infranta dal medesimo destino nello stesso Tempo del Male, riflette pragmaticamente con il suo sistema di analisi – influenzato da Heidegger – che contribuisce a renderla una pensatrice originale, trasversale ai diversi campi del sapere e delle specialità accademiche.
Lei cerca di reagire con altri strumenti filosofici, adottando il concetto greco di φρόνησις, cioè la capacità di giudicare identificata anche con l'intuizione e che è in sostanza quella forma di conoscenza capace di indirizzare la scelta. Per la cultura greca questo concetto era la virtù principale dello statista, e del politico in genere, a differenza della saggezza, tipica del filosofo. Hannah Arendt ritiene che questa capacità rifletta quello che viene definito il senso comune, il buon senso, poiché si basa sulla natura del mondo in quanto realtà comune. Dunque l'oggettività del mondo viene, secondo lei, letta dalla soggettività dell'uomo attraverso i cinque sensi. Il giudizio, per la Arendt, deve essere affiancato al πείθειν ovvero alla capacità del persuadere, che lo statista o il politico devono possedere per entrare in empatia con la comunità.
Lui fu il cofondatore del movimento antinucleare nel 1954. Pubblicò il suo diario filosofico di una conferenza internazionale su Hiroshima e la sua corrispondenza con il pilota Claude Eatherly che guidò la spedizione per lo sganciamento della bomba su Hiroshima. I suoi libri politicamente aspri dal 1960 inclusero una lettera aperta al figlio di Adolf Eichmann, un discorso sulle vittime delle guerre mondiali. Nel 1967 prese parte come giurato al Tribunale Russell per rendere pubbliche le atrocità del Vietnam.
Lei, nel suo resoconto del Processo ad Eichmann (1960 – 1962) per il New Yorker (che divenne poi il libro La banalità del male – Eichmann a Gerusalemme, 1963) sollevò, tra mille polemiche, la questione di come il male potesse essere non essere radicale: anzi forse era proprio l'assenza di radici, di memoria, il non ritornare sui propri pensieri e sulle proprie azioni mediante un dialogo con se stessi (dialogo che Arendt definisce due in uno e da cui, secondo lei, scaturisce e si giustifica l'azione morale) che aveva trasformato personaggi spesso banali in autentici agenti del male. Questa stessa banalità aveva reso, come accaduto nella Germania nazista, un popolo acquiescente, quando non complice, con i più terribili misfatti della storia, contribuendo a far sentire l'individuo non responsabile dei propri crimini, senza il benché minimo senso critico.
E così espresse la sua protesta verso l'omologazione cui la costringeva la dottrina razzista della Germania hitleriana: «Se sottolineo tanto esplicitamente la mia appartenenza al gruppo degli Ebrei cacciati dalla Germania a un'età relativamente giovane è perché desidero prevenire taluni malintesi che insorgono fin troppo facilmente quando si parla di umanità. In questo contesto, non posso passare sotto silenzio il fatto che per molti anni ho ritenuto che la sola risposta adeguata alla domanda: chi sei? Fosse: un'Ebrea. Solo questa risposta teneva conto della realtà della persecuzione...».
Lui riesce a trovare parole di gratitudine per essere riuscito a salvaguardare la propria lingua ed averne scoperta una nuova, o altre ancora, e per aver potuto dare spazio a quella vita intellettuale che ha permesso a tanti profughi di andare oltre «un’esistenza balbuziente » grazie alla scrittura. Proprio per questo, dice, «non c’è nessuno che meriti la nostra dedica quanto lei, la nostra maestra: l’epoca buona di miseria del nostro esilio».
E afferma, in modo provocatorio, di essere un «conservatore ontologico, poiché oggi ciò che conta è più di tutto conservare il mondo, qualunque esso sia».
Dopo il 1945 viviamo, per Anders, in un’epoca con una scadenza, potranno essere anni, secoli, forse millenni, ma una cosa è certa: nessuno di noi potrà assistere alle conseguenze che porteranno a un mondo senza l’uomo. E conclude, in un’intervista intitolata Sulla fine del pacifismo: «Nei cimiteri in cui riposeremo nessuno verrà a piangerci. I morti non possono piangere altri morti».
E, piano piano, Günther Anders e Hannah Arendt si avvicinano di nuovo, le loro riflessioni filosofiche si incontrano e si incrociano, maturano nell’esperienza del Male – ritirandosi però, pure e intatte, nel momento escatologico.
Dalla consapevolezza di ciò che stava accadendo all’umanità intera, nacque in Günther Anders l’esigenza di una nuova filosofia: un incrocio tra metafisica e giornalismo, cioè un filosofeggiare che tenesse al centro della riflessione la condizione odierna dell’uomo. Dopo lo sgancio dell’atomica, decide di dedicarsi all’impegno politico, interrompendo così la sua ricerca filosofica.
Questa scelta viene spiegata da Anders nel secondo volume de L’uomo è antiquato dove afferma: «sentivo assai più ineludibile il partecipare effettivamente alla battaglia combattuta da migliaia di persone contro una simile minaccia; e dunque, se ho piantato in asso il mio primo volume, è stato perché non volevo piantare in asso la cosa che in esso avevo rappresentata».
Hannah Arendt, invece, difese il concetto di “pluralismo” in ambito politico. Secondo lei, grazie al pluralismo, il potenziale per la libertà politica e l'uguaglianza tra le persone si sviluppano. Importante è la prospettiva di inclusione dell'altro, ovvero di ciò che ci è estraneo.
Senza grottesche e pericolose evasioni dalla realtà, feriti e consapevoli, impegnarono le loro Vite per amore del mondo.
©Barbara de Munari
- Dettagli
- Scritto da Barbara de Munari
- Visite: 694
Il rabbino Elio Toaff racconta l’orrore
di Sant’Anna di Stazzema – 12 agosto 1944
Il 12 agosto 1944, il giorno della strage dei 560 martiri di S. Anna di Stazzema, il futuro rabbino capo di Roma Elio Toaff era nella zona dell’eccidio. Tale notizia apparve il 30 ottobre 1982 sul quotidiano “La Repubblica” che pubblicò l’intervista concessa da Toaff al giornalista Giampaolo Pansa.
Nato a Livorno, dove anche suo padre era rabbino, Elio Toaff rievocò gli anni del fascismo e la sua cattura da parte di un reparto delle SS comandato – come apprese dopo – dal maggiore Walter Reder, che nell’estate 1944 aveva la sua stessa età, 29 anni.
Toaff ammise di non essere più stato a Sant’Anna di Stazzema. Bazzichi, per anni sindaco di Stazzema, ebbe l’idea di invitarlo ufficialmente a S. Anna, per onorare le vittime della strage. Ne parlò con il giornalista Giorgio Giannelli, fondatore e direttore, per diversi anni, del periodico “Versilia oggi”. Parlando di S. Anna Toaff anni fa disse: “Posso chiamarla la piazza della mia vita? Forse sì. Ogni uomo ha una storia al centro della propria vita. E ogni storia ha un luogo. Il mio luogo è la piazza di Stazzema”. Il perché ce lo spiega poco dopo…
“Nel 1941 divenni rabbino di Ancona. Poi, nel 1946, fui rabbino di Venezia. E nel 1951 arrivai a Roma di cui poi divenni il rabbino capo. Che cosa significa. Per intenderci, fui il rabbino capo d’Italia perché presiedevo la consulta rabbinica italiana. Roma è la più grande comunità ebraica del nostro paese. Oggi gli italiani ebrei sono un po’ meno di quarantamila, i deportati nei campi di sterminio nazisti furono ottomila. Vivi ne ritornarono 213.
La storia che sta al centro della mia vita comincia nell’anno della deportazione. Da Ancona sfollai a Fabriano con mia moglie e il primo dei nostri quattro figli, Ariel, che quando fui arrestato dalle SS di Hitler aveva un anno.
Nel settembre 1943 mi resi conto che dovevo fuggire anch’io. Gli ebrei di Ancona erano circa seicento, i più anziani li nascosi in case di contadini. I più giovani gli aiutai a passare il fronte, sui pescherecci che partivano da Ortona a Mare.
Poi ce ne andammo anche noi in Toscana, dove ci rifugiammo a casa dei miei, ad Orciano Pisano. Eravamo arrivati da qualche ora che si fece vivo il maresciallo dei carabinieri. Parlò con il fattore. ‘So che qui ci sono degli ebrei. Ditegli di prepararsi perché oggi pomeriggio alle tre verrò per arrestarli’. Ha capito? Un uomo straordinario. Quanti di noi si sono salvati grazie ad uomini come quel maresciallo. Comunque, si dovette di nuovo partire. Andammo in un altro rifugio e poi da mio suocero, Ezio Luperini, il quale meriterebbe una pagina a parte.
Era il più grande latifondista dell’Isola d’Elba, ma era anche socialista. Così regalò tutte le sue terre ai contadini e divenne operaio all’Ilva, macchinista della ferrovia a scartamento ridotto della miniera di Capoliveri. Fu il primo sindaco socialista di Capoliveri dal 1914 al 1922.
Dopo la marcia su Roma, emigrò negli Stati Uniti, da dove poi ritornò poco prima dell’inizio della seconda guerra mondiale.
Ci nascondemmo in una villetta alle Focette per poi fuggire ancora, questa volta a Val di Castello, dove ci sistemammo nel gabinetto chimico delle miniere. Ormai si era nell’estate del 1944, in Versilia i partigiani combattevano a ridosso del fronte, io collaboravo con l’avvocato Salvadori, un socialista versiliese, uno dei capi della resistenza locale che teneva i contatti con i giovani delle formazioni partigiane.
La notte dell’8 agosto 1944 uscii dal rifugio alla ricerca di mio cognato. Era cominciato un grande rastrellamento e volevo avvisarlo. Mentre mi arrampicavo sulla montagna, sopra le miniere, mi presero le SS. Dopo ho saputo che li comandava il maggiore Walter Reder (un ufficiale della stessa età del rabbino Toaff, ventinove anni) che poi successivamente farà anche l’eccidio di Marzabotto dove furono trucidate 1836 persone. Le SS battevano la montagna e noi prigionieri si camminava davanti a loro, portando sulle spalle le casse di munizioni, gli facevamo da muli da soma e anche da scudo. Sul monte Gabberi il reparto cadde in una imboscata, nessuno di noi ostaggi fu colpito ma sette o otto tedeschi morirono.
Ci fecero portare i feriti a valle fino a Farnocchia di Stazzema. Qui gli opici delle SS bombardarono le case coloniche. Dall’alto si vedevano le fiammate, il fumo, la gente che scappava come formiche dai formicai. Poi ci condussero a Montramito, in undici dentro una stalla.
Di questi undici ero l’unico ebreo e non solo ero ebreo, ma un rabbino ebreo. I tedeschi ci fecero spogliare quasi nudi. Io avevo con me il taled, lo scapolare che si porta noi ebrei, lo zucchetto e anche una foto di mio fratello emigrato in Palestina, dietro c’era scritto Tel Aviv. Non so come riuscii a nasconderli alle SS, che ogni due ore entravano nella stalla. Entravano e ci ferivano con i calci dei fucili e con le baionette. Ho ancora i segni delle baionettate in questo braccio.
Il secondo giorno dei miei compagni vennero fatti uscire dalla stalla. Sentimmo un gran trambusto. Poi delle grida. Poi più niente. Guardammo da una fessura. Quei sei li avevano impiccati nel cortile. Pendevano dagli alberi con la gola straziata dal filo spinato. Allora capimmo quale sarebbe stata la nostra sorte.
All’alba del terzo giorno diedero a ciascuno di noi una pala e un piccone e ci trascinarono in un uliveto. Un tedesco prese le misure sul terreno poi ordinò: “Ognuno si faccia la fossa“.
Dopo un po’ che lavoravo mi dissi: ‘No, io non scavo più’. Gettai la pala e cominciai a pregare, allora si avvicinò un capitano delle SS. Mi chiese: ‘Perché non lavori?’.
‘Perché sono malato di cuore’.
Chiese ancora: ‘Hai famiglia?’.
‘Sì, una moglie e un bambino di un anno e mezzo’.
Lui mi disse: ‘Anche io ho moglie e un figlio a Vienna, sono austriaco, faccio il professore di matematica’.
Dopo questo dialogo, un po’ assurdo, il capitano se ne andò. Le altre SS ci osservavano ridendo, ci sputavano addosso e orinavano su di noi. Ormai le fosse erano scavate e l’ufficiale ritornò. Mi chiese: ‘Tu sei fascista?’.
Risposi di no e lui ordinò: ‘Questo lasciatelo venire fuori’. Le SS mi tirarono su, poi cominciarono a sparare sugli altri quattro.
I miei compagni non erano ancora morti che già i tedeschi li coprivano di terriccio. Vedevo questi mucchi di terra sussultare, di sotto venivano dei lamenti, mi sembrava di uscire di senno. Il capitano mi offrì una pistola. ‘Dagli tu il colpo di grazia’. Non so come ebbi la forza di rifiutarmi, dopo un istante una delle SS cominciò a picchiarmi con il calcio del fucile. Svenni. Mi risvegliai nella stalla. Un tedesco mi disse: ‘Tu andrai a La Spezia e poi in Germania’.
Ma il camion che doveva condurmi via incappò nei partigiani e allora mi portarono nelle scuole sempre a Montramito. Stavamo in tre o quattro nello sgabuzzino delle scope, c’era anche un vecchio. L’avevano preso con la nipote di diciotto anni. La ragazza era stata portata su, nella camera dei soldati e il vecchio piangeva. Verso mezzanotte si fece vivo il misterioso capitano di Vienna prese me e un altro giovane e ci spinse sulla strada mormorando: ‘Via, via!”, dopo un po’ cominciò a sparare in aria con la pistola, io mi nascosi in un campo. Il giorno seguente mi trascinai dai miei a Val di Castello, quasi non mi riconobbero. Ero una larva tremante, coperta di sangue.
Ma le SS mi cercavano ancora, erano dei ragazzi poco più che adolescenti. Cercavano la spia bionda, cioè mio cognato e quello scappato, cioè me, allora fuggimmo in direzione del Capannaccio in montagna. Conoscevamo un pastore in contatto con i partigiani. Per arrivarci si doveva passare per il paese di S. Anna di Stazzema. Ma proprio su S. Anna quel sabato correvano voci tremende:‘ I tedeschi radunano molti ostaggi. I tedeschi li hanno visti venire da S. Anna con le braccia sporche di sangue’. Ed ecco Elio Toaff che prosegue il terribile racconto a “ La Repubblica”.
‘Quando arrivammo a S. Anna era sera tardi, la sera del sabato 12 Agosto. All’inizio del paese vidi una casa con l’uscio spalancato. L’uscio cigolava mosso dal vento, guardammo dentro la casa immersa nel silenzio. In cucina c’era una donna sventrata a colpi di baionetta. Proseguimmo sbigottiti. C’era la luna. Quando fummo vicini alla spianata della chiesa cominciammo a sentire un odore di bruciato, come di carne che arrostiva.
Quella piazza di S. Anna in quella notte… indescrivibile, fra il platano e un cippo c’erano decine e decine di persone uccise. Sui corpi le SS avevano gettato paglia, le panche della chiesa e poi la benzina. Tutto bruciava, se uno non avesse visto non può capire, c’erano molte donne e bambini. Tanti bambini, tanti bambini. Tutti assassinati.
‘A S. Anna non ho più voluto rimetter piede. Mi invitano sempre, ma non mi regge il cuore per tornarci. Per anni, ogni anno, il 12 Agosto, mi prendeva un tremito senza ragione. E non ho dimenticato. Ho rivisto S. Anna di Stazzema quando la televisione ci ha mostrato le immagini dei civili palestinesi uccisi a Sabra e Chatila. E mi sono rivisto sulla piazza di S. Anna la mattina di quell’altro sabato, davanti alla sinagoga, mentre camminavo tra i feriti a terra, nel sangue, verso il bambino Stefano che moriva’.
[Per gentile concessione del Figlio, Rav Ariel Toaff]. Fonte: https://www.larno.it/

In foto Lia, Ariel e Elio Toaff, 1942 - Museo ebraico di Roma
- Dettagli
- Scritto da Barbara de Munari
- Visite: 540
Ci sono sempre più versioni di ogni storia che viene raccontata al sorgere del sole, dopo una notte di baldoria tra sigari, canzoni e qualche bicchiere di troppo. Soprattutto nei bar di Plaza Garibaldi, a Città del Messico, un posto così ricco di tradizioni e leggende di origini sconosciute che molto spesso si intrecciano con la vita di alcune persone, che diventano leggenda anch’esse.
Chavela Vargas è stata una leggenda per gran parte della sua vita rara.
Aveva 17 anni, Chavela, quando finalmente arrivò a Città del Messico, nel 1936. Scappava dalla sua famiglia, dai suoi genitori che, quando si separarono la abbandonarono da una zia, perché nessuno dei due la voleva. Scappava dalla poliomielite, oramai completamente regredita, che da bambina la “ruppe” rendendola quasi cieca, ma che riuscì a superare anche grazie all’aiuto di uno sciamano che incontrò per caso, durante una delle sue primissime fughe da casa. Scappava da quel prete che le impedì di entrare in chiesa perché rara, strana. Perché amava arrampicarsi sugli alberi, indossare i pantaloni e legare i capelli in una grossa treccia e preferiva baciare le ragazze. Scappava dalla Costa Rica perché oramai le stava stretta, perché non era più la benvenuta.
Il Messico e la sua capitale erano in piena rivoluzione artistica e culturale. Intellettuali di e da tutto il mondo venivano attirati in questa giovane metropoli in fermento, mentre nel resto del mondo si respirava aria di guerra. Per Chavela era un sogno. Come altre prima di lei si accorse che qui le donne non dovevano chiedere il permesso di essere libere. Qui si poteva pretendere e ottenere rispetto per quello che si faceva. Tutto era possibile e tutto era consentito. Chavela voleva vedere l’alba tutti i giorni, voleva bere fumare sigari, voleva divertirsi e sentirsi libera. Soprattutto però, Chavela voleva cantare. E aveva una gran voce, Chavela.
I primi anni in Messico si trascinarono tra lavoretti improvvisati e nottate infinite, tra alcol e canzoni d’amore. Un giorno, però, un amico pittore o un’amica modella, secondo chi racconta la storia, le disse di una festa organizzata in quella casa dalle mura blu sempre frequentata da artisti e intellettuali. Chavela non conosceva nessuno, ma che importa. Non si rinuncia mai alla possibilità di fare baldoria e a della tequila gratis. Fu così che, mentre ballava davanti a un giradischi, con un sigaro in una mano e una bottiglia piena solo a metà nell’altra, la padrona di casa la notò.
Era una donna vestita con abiti tradizionali messicani, fiori nei capelli e delle sopracciglia pronte a spiccare il volo. Frida Kahlo le chiese di ballare. Chavela non tornò a casa quella notte, nemmeno in quelle successive. Sì fermò a Casa Azul per mesi. Era il 1939. Frida stava divorziando da Diego Rivera dopo averlo trovato a letto con la sua amata sorella. Si risposarono l’anno successivo perché, nonostante scappatelle e tradimenti di entrambi non potevano vivere l’uno senza l’altra. Chavela entrò nella vita di Frida come in tutte le storie che si rispettano: al momento giusto. Furono mesi di passione travolgente e intesa perfetta, fino al giorno in cui senza preavviso Chavela prese Frida da parte e le disse «Non posso fermarmi più, devo andare». E Frida forse rimase ferita, ma la lasciò andare.
Nel frattempo arrivarono i primi ingaggi nelle cantine, nei locali vicino a Plaza Garibaldi.
Le prime volte provò anche a seguire le regole, esibendosi in abiti femminili, indossando fiocchi e tacchi alti e a cantare le vivaci melodie della musica ranchera. Non funzionò, non si sentiva a proprio agio. Come darle torto. Come si fa a cantare con un abito che quando alzava le braccia nel mezzo della canzone mostrava tutto quello che c’era sotto? O a salire sul palco con quei maledetti tacchi che rischiavano sempre di farla cadere, davanti a tutti? Un giorno, senza dire niente a nessuno, si presentò sul palco con i capelli legati in una treccia strettissima e il suo amato completo da mariachi sotto al poncho rosso che sarebbe diventato il suo marchio di fabbrica. Prese la chitarra, se l’appoggiò al petto e cominciò a percuoterla. Cominciò a cantare, lentamente, con serietà, con la sua voce profonda ammorbidita dalla tequila. Il pubblico ne rimase stregato. Chi è questa donna sul palco che si veste come un uomo, che canta come un uomo? Chi è questa donna che stravolge il significato di una canzone che racconta la storia di una donna simbolo di libertà, facendola diventare ambigua, erotica? Chi è questa donna con il poncho rosso? Chi è questa Chavela Vargas?
Fu in questo periodo che incontrò José Alfredo Jiménez, già affermato musicista e compositore di ballate rancheras. Ben presto nacque un’amicizia destinata a cambiare la storia della musica messicana. Era il 1948. I testi di José Alfredo Jiménez erano scritti e pensati per essere cantati da uomini in pena da “amores y desamores”. Chavela, con il suo vestirsi da uomo, con il suo cantare senza mai cambiare pronomi, con il suo essere lesbica senza nasconderlo, senza mai nemmeno sbandierarlo prese questi testi, legati a una tradizione machista e li rese universali. Perché non c’è nulla di più universale dell’amore perduto e tradito, della nostalgia, della solitudine, il senso di vuoto e del dolore causato dall’assenza. Insieme spogliarono la musica ranchera di tutto ciò che era superfluo. La liberò dagli stereotipi folkloristici e festaioli, rivestendola di melodramma, della disperazione che segue le sbronze. A Chavela bastavano un paio di chitarre e la sua voce.
Chavela cominciò ad esibirsi nei teatri, dove continuò la sua vita sregolata tra alcol, donne e musica. La fama di quella donna dal poncho rosso superò i confini nazionali e arrivò ad Hollywood. Elizabeth Taylor, Clark Gable, Lana Turner. Scendevano fino ad Acapulco dove potevano passeggiare per la spiaggia senza essere fermati e passare le serate ad ascoltare la calda voce di Chavela Vargas. Anche lei fu invitata al primo leggendario matrimonio tra Elizabeth Taylor e Richard Burton. Quella notte si narra che tutta Hollywood andò a letto con qualcuno. Il mattino dopo, al suo fianco, c’era nientemeno che Ava Gardner, che aveva un debole per lei da un po’. La grande festa finì nel 1973, con la morte di José Alfredo Jiménez, consumato dalla cirrosi epatica dovuta all’alcolismo. Il dolore, l’alcol, la solitudine la consumarono. Nel 1979 si ritirò dalle scene. Per 12 anni non diede più sue notizie. Pensarono tutti che fosse morta.
A El Habito, un piccolo locale di Città del Messico appena aperto e gestito da due ragazze, una seraa del 1991 cominciò a correre una voce. Sì, era proprio lei, Chavela Vargas, tornata dal mondo dei morti, venuta per ascoltare un po’ di musica. Com’era diversa però questa Chavela. I capelli quasi completamente bianchi, una ragnatela di rughe in faccia e il sorriso beffardo di sa di aver attraversato l’inferno ma di aver finalmente trovato la serenità. Solo il poncho rosso non era cambiato. Durante l’ultimo periodo del suo isolamento volontario aveva trovato rifugio in una comunità di sciamani ed era diventata una di loro. Non toccava alcol da allora. Ma erano 12 anni che non cantava più. Il palco la terrorizzava, e poi non aveva mai cantato sobria. Si ricordava del pubblico che pendeva dalle sue labbra quando cantava, della tensione che creava con i silenzi. Si ricordava del modo in cui la voce quasi si rompeva a metà delle note lunghe, come un lamento. E della pace che trovava quando cantava. Perciò salì sul palco, abbracciò la chitarra, cominciò a percuoterla.
Fu la rinascita. Riprese a fare concerti tutte le settimane, sempre a El Habito. In tutto il mondo si sparse la voce del ritorno di Chavela Vargas. Tutti volevano ancora sentir cantare quella sciamana con l’abito da mariachi sotto al poncho rosso. Perché quando cantava sembrava cantare solamente per te. Hai mai commesso errori nella tua vita, nelle tue storie d’amore? Sembrava chiederti. I tuoi errori sono un bene, ne valgono sempre la pena. Sono la cosa più importante che ti sia capitata. Fanne ancora se puoi. Anche io ne ho commessi tanti. E siamo qui entrambi.
Almodovar volle conoscerla per farla cantare per i suoi film. La portò a Madrid e a Parigi. Chavela cantò nuovamente nei teatri.
E cantò ancora e ancora.
Nel 2003 interpretò la canzone che la rese famosa in tutto il mondo, una delle canzoni più conosciute e riconoscibile della tradizione messicana, La Llorona. La Llorona è lo spirito di una donna che piange la morte dei suoi figli. Nell’iconografia sudamericana rappresenta la morte. Lei che era stata creduta morta in vita ed era tornata. La cantò nel film sulla vita di Frida Kahlo. La vita a volte ha modi curiosi di incastrare tutti i pezzi.
Nel 2012, a 93 anni pubblicò il suo ultimo disco, quello dedicato a Federico Garcia Lorca, il poeta che adorava, morto troppo giovane durante la guerra civile spagnola.
Si ammalò gravemente pochi giorni prima del concerto di presentazione a Madrid. Non sembrava essere in grado di cantare. Lei volle provarci lo stesso. Cantò con un filo di voce. Sapevano tutti sarebbe stato il concerto di addio di Chavela Vargas. Lo sapeva il pubblico, lo sapeva lei.
Se quella sera non morì sul palco come avrebbe voluto forse è solo perché questa storia non è ancora stata raccontata abbastanza. O forse perché la Llorona in persona aveva deciso che Chavela sarebbe dovuta morire in Messico, nel suo Paese. Chissà.
Morì nella sua casa tra le montagne di Cuernavaca che l’avevano ospitata negli ultimi anni e che tanto aveva amato. Era il 5 agosto.
Il giorno del funerale i mariachi scesero si riunirono in Plaza Garibaldi per rendere omaggio cantando a quella bara coperta da un poncho rosso. Furono lacrime e festa, come nella migliore tradizione messicana. Tutti l’avevano ormai riconosciuta come uno di simboli della cultura messicana. Perché sì, lei era messicana. E se qualcuno le faceva notare che era nata in Costa Rica rispondeva «Noi messicani nasciamo dove cazzo ci pare», come amava ripetere.
©Barbara de Munari

Pagina 10 di 53

